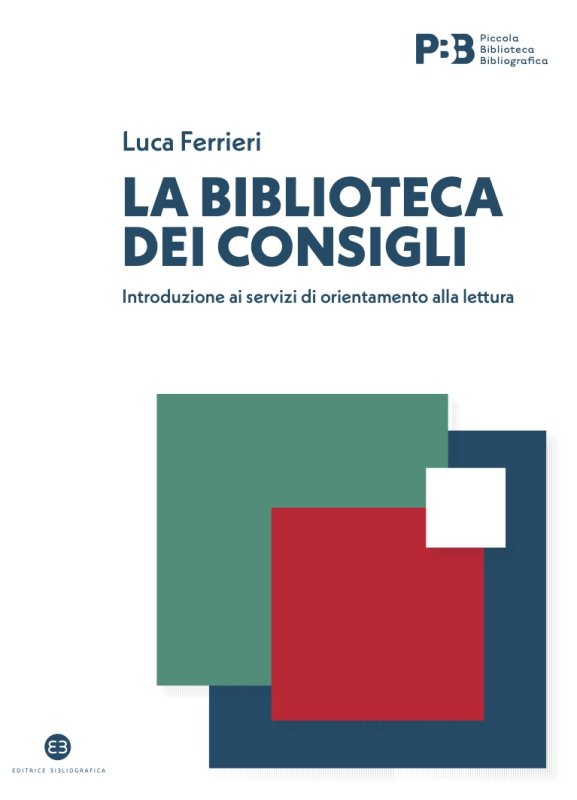
Il nuovo libro, appena pubblicato, di Luca Ferrieri (già direttore della Biblioteca di Cologno Monzese e studioso e promotore dei servizi bibliotecari e della lettura, oltre che autore di numerosi altri libri, di cui mi piace ricordare almeno La biblioteca che verrà, anch’esso oggetto di riflessione e discussione sul blog) è La biblioteca dei consigli. Introduzione ai servizi di orientamento alla lettura (Editrice Bibliografica). Il testo è una presentazione approfondita del servizio che negli Stati Uniti viene chiamato Readers’ Advisory Service e che, in modo forse non troppo brillante, nel sottotitolo viene tradotto come “orientamento alla lettura”. Fondamentalmente si tratta di un servizio parallelo a quello di “reference” che offre consigli su libri da leggere. Qualunque bibliotecaria al front-office di una biblioteca si è sicuramente sentita rivolgere questa domanda: “Mi consiglia un libro?”. Negli anni ‘90 (quando ero ancora giovane e idealista) mi lanciai in un’infiammata discussione all’interno di AIB-CUR (la lista di discussione dei bibliotecari italiani) sulla liceità, a livello di etica professionale, di cercare di dare risposta a questa domanda da parte della bibliotecaria. Essendo il mio lavoro all’epoca costituito per la maggior parte di front-office, quella domanda mi era posta quasi quotidianamente e cercavo di sfruttare sia le mie passioni letterarie, sia le mie competenze biblioteconomiche dell’universo editoriale per rispondere nel miglior modo possibile e sarei stato il primo a pensare di non fare bene il mio lavoro se mi fossi rifiutato di offrire un minimo di guida al lettore. Ma la vulgata, soprattutto ai piani alti dell’Associazione Italiana Biblioteche, era (all’epoca?), quella che una risposta di tal genere era impropria e non professionale: avrei dovuto invece “orientare” (per questo mi da fastidio come è stato tradotto “advisory”) l’utente mostrando dove, all’interno della biblioteca, avrebbe potuto trovare i romanzi, suddivisi nei vari generi, la saggistica, le opere di consultazione, ecc. In sostanza avrei dovuto deviare la richiesta precisa di un consiglio di lettura in una richiesta di “information literacy” relativa al sistema di collocazione della collezione in uso. Questo atteggiamento, a dir la verità, non è ancora del tutto scomparso se, nel Codice deontologico dei bibliotecari è possibile leggere (al punto 1.5):
Non spetta ai bibliotecari, a differenza di altre figure (ad esempio genitori, insegnanti, ricercatori, critici o librai) […] esprimere valutazioni positive o negative sui documenti richiesti, utilizzati o messi a disposizione del pubblico. I bibliotecari possono fornire indicazioni e consigli sugli strumenti e i metodi più efficaci per la ricerca, la selezione e la valutazione di documenti e informazioni, ma si astengono dal fornire consulenze in ambiti professionali diversi dal proprio.
Sostanzialmente “fornire indicazioni e consigli sugli strumenti e i metodi più efficaci per la ricerca, la selezione e la valutazione di documenti e informazioni” è l’attività di information literacy apprezzata e approvata, mentre “ fornire consulenze in ambiti professionali diversi dal proprio” è dare consigli di lettura alle lettrici che te li chiedono, cosa appunto disapprovata. Per questo ho letto con estremo interesse il nuovo libro di Ferrieri e lo consiglio (ahi!) in modo appassionato a tutti i colleghi e le colleghe bibliotecari/e, anche come modo per aggiornare l’impostazione professionale e allinearla agli standard più avanzati, cercando di lasciarci alle spalle i residui polverosi delle biblioteche elitarie riservate a pochi studiosi.
Il libro analizza il Readers’ Advisory Service fornendo un quadro della sua storia e del suo funzionamento nelle biblioteche statunitensi, ma anche compiendo un’approfondita disamina dei concetti e delle pratiche relative al “consiglio” e alla “lettura” (e in quale – del resto – tra i libri di Ferrieri non c’è una disamina della pratica del leggere?). In particolare la trattazione teorica relativa al “consiglio” mi porta a riflessioni che esulano dall’ambito strettamente bibliotecario e quindi la presentazione del libro qui di seguito vedrà: 1) un riassunto del servizio di RAS così come presentato da Ferrieri; 2) un tentativo di allargare il concetto di “consiglio” ad ambiti non esclusivamente biblioteconomici; 3) uno sguardo alla biblioteca consigliante che verrà.
1. READERS’ ADVISORY SERVICE
Innanzi tutto la definizione del servizio:
I Readers’ Advisory Services sono servizi forniti da bibliotecari preparati e specializzati volti a soddisfare i bisogni di lettura degli utenti attraverso il suggerimento di opere, di autori, di modalità di approccio ai libri e alla letteratura, utilizzando a tale scopo sia una serie di strumenti di reference, sia la conoscenza diretta dei gusti e delle abitudini di lettura dell’utente. [definizione ripresa da Joan M. Reitz, Dictionary for Library and Information Science, Libraries Unlimited, 2004] p. 121
Ferrieri descrive il servizio di consulenza come parallelo al servizio di reference. Presenta in questo modo la distanza tra i due:
…quando in un contesto di reference cerchiamo una “risposta” (tipicamente nel caso della cosiddetta risposta “fattuale”), proviamo a collegare il vasto e vago universo informativo dell’utente al puntuale e biunivoco punto o documento che contiene l’informazione desiderata. Nel consiglio facciamo il percorso opposto: apriamo, spalanchiamo, il nucleo del desiderio di lettura del lettore per alimentarlo e sparpagliarlo su direttrici molteplici. Ovviamente questa rivoluzione del punto di vista, se vogliamo mantenerla tale, deve evitare di tracciare nuovi confini, nuovi paradigmi, e quindi uno dei suoi benemeriti contraccolpi sarà quello che anche nel reference cominceremo ad abbandonare la logica biunivoca a favore di quella policentrica, e che nel consiglio affineremo invece la mira e la prospettiva del desiderio per permettergli di intensificare il suo focus, come una lente di ingrandimento. (p. 130)
Nell’approccio alla richiesta dell’utente/lettrice il colloquio di reference, volto a precisare e chiarire la richiesta informativa, deve diventare un’anamnesi, una discussione in cui è fondamentale l’ascolto e in cui non è solo alla bibliotecaria che spetta di far domande. Per quanto siano stati messi a punto degli strumenti che permettono di aiutare a chiarire quale sia il desiderio di contenuti ed emozioni della lettrice (ad esempio tramite testi come: Neal Wyatt e Joyce G. Saricks, The Readers’ Advisory Guide to Genre Fiction, 3. ed., ALA Editions, 2019; Diana Tixier Herald e Samuel Stavole-Carter, Genreflecting. A Guide to Popular Reading Interests, 8. ed., Bloomsbury Publishing, 2019; ma anche tramite siti che chiedono alla lettrice quale siano le sue preferenze per arrivare a presentare dei testi che siano in linea con essi come Whichbook), la bibliotecaria non può esimersi da uno scambio di prospettive di lettura. Lettrice e bibliotecaria devono entrare (senza la preoccupazione di offrire un risultato in un tempo limitato) in una comunità di lettura (che non comprende solo loro due, ma tutto il pubblico della biblioteca con i relativi feedback sui libri letti) per far sì che la seconda possa usare strumenti come la suddivisione per generi e temi, le “folksonomie”, per individuare quale lettura la lettrice potrà in quel momento apprezzare. Il problema di questi strumenti è che non sono di creazione biblioteconomica: i generi e i temi sono uno strumento di marketing delle case editrici e le folksonomie, il social tagging sono imprecisi e ridondanti. Anni fa discutevo con Denise Picci (di cui Ferrieri cita un intervento) della possibilità di creare un “authority file” per la catalogazione semantica della narrativa (cosa che interessava a lei) e dei videogiochi (cosa che interessava a me). Cosa non impossibile se pensiamo che LiBeR Database ha fatto esattamente questo con i libri di fiction per bambini e ragazzi e che, all’interno del Polo bibliotecario piacentino utilizziamo le parole chiave proposte dai catalogatori di LiBeR per “taggare” questa tipologia di libri e rispondere alle richieste di bambini, genitori e insegnanti che cercano libri di narrativa su argomenti, personaggi, temi particolari. Comunque i consigli non necessariamente devono prendere la strada della “somiglianza” (di genere: se ti è piaciuto Isaac Asimov – utilizzo esempi dalla fantascienza che è l’ambito narrativo che mi è maggiormente congeniale – prova a leggere un libro di Arthur C. Clarke; di tema: se ti è piaciuta la serie di Fallout, prova a leggere la serie di Metro, magari i due spinoff di Tullio Avoledo, scritti decisamente meglio della trilogia originale di Glukhovsky) ma anche quello della “differenza” tramite il meccanismo della serendipità e che può generare un risultato solo tramite un entrare in risonanza tra la lettrice e la bibliotecaria in modo che quest’ultima possa proporre opere apparentemente lontane dal mood dichiarato, ma che si agganciano ad elementi segnalati dalla lettrice come amati e/o fondamentali. In questo senso
Il consiglio appare come l’ulteriore e necessario passaggio dalla biblioteca delle collezioni a quella delle relazioni, dalla biblioteca che cataloga il mondo a quella che lo inventa, lo interpreta e lo innerva. (p. 13)
e
…il consiglio è un abbraccio, non una lezione: e ci chiede, come prima cosa, di mettersi nella pelle (non solo nei panni) dell’altro, sia quando lo diamo, sia quando lo riceviamo. (p. 15)
Ferrieri inoltre distingue anche tra consiglio attivo e passivo: il primo è il servizio vero e proprio di consulenza, mentre il secondo sono invece le vetrine, le proposte bibliografiche, la segnaletica. In questo senso, mi sembra di poter aggiungere, tutta l’attività di creazione e manutenzione della collezione è implicitamente un’attività di “consiglio” passivo. Dato che nessuna biblioteca può porsi l’obiettivo di possedere tutta la produzione editoriale, l’inevitabile selezione è effettuata con l’intento di inserire nella collezione titoli coerenti con quelli già presenti e interessanti per il pubblico sia in una prospettiva di breve (il richiamo dei bestseller) sia in una di lungo periodo (i classici, i manuali, ecc.). Ciò che è presente in biblioteca è già il frutto di una selezione, che si presuppone accurata, per mettere a disposizione il meglio delle risorse editoriali per il pubblico di riferimento.
2. CONSIGLI E GIUDIZI
Tutta la parte teorica del libro sul concetto di “consiglio” mi ha fatto tornare al periodo pre-bibliotecario, in cui mi sono avventurato in un tentativo di estetica del giudizio. Premesso che alla base del consiglio c’è sempre un giudizio (non è possibile dare un consiglio basandosi esclusivamente su repertori esterni, ad un certo punto sarò costretto a scegliere tra valutazioni diverse, a ridurre il numero di libri che rientrano nei criteri comunicati, e questo è possibile farlo solo utilizzando il giudizio personale che può basarsi su competenze personali e/o sulla capacità di valutare recensioni/pareri/votazioni). Nel saggio scritto all’epoca (oggi forse perduto, ma mai dire mai: l’altro giorno rovistavo in un vecchio hard disk esterno e annidate nei vari backup ho trovato cartelle con gli articoli per Manifesto e Mucchio Selvaggio di almeno dieci/vent’anni fa) distinguevo tra giudizio soggettivo e giudizio intersoggettivo (argomentando che non è possibile un giudizio oggettivo, essendo sempre il giudizio condizionato dalla cultura in cui si è immersi e dall’ideologia personale e del gruppo sociale a cui si appartiene). La differenza tra i due tipi di giudizio è che il primo è insindacabile (“mi piace Snow Crash di Neal Stephenson” è un’osservazione su cui nessuno può obiettare, neppure quelli a cui il romanzo non piace perché sto parlando delle mie preferenze) mentre il secondo ha bisogno di essere giustificato e condiviso. Se io dico “Snow Crash è uno dei romanzi migliori della fantascienza contemporanea (quella successiva all’avvento della Rete)” faccio un’affermazione che non è più insindacabile: devo esporre le motivazioni del mio giudizio con la consapevolezza che, per quanto buone possano essere, non troveranno mai l’accordo universale, anzi, molto probabilmente, dovranno confrontarsi con giudizi opposti altrettanto bene argomentati (a proposito: qui il mio giudizio su Snow Crash). Se fosse possibile un giudizio oggettivo, si tratterebbe non di un giudizio estetico ma di un giudizio scientifico, la cui falsificabilità sarebbe legata unicamente ad una fallacia nell’argomentazione. Al contrario il giudizio estetico è sempre fondamentalmente soggettivo, anche se tale soggettività vuole e deve essere condivisa. E siamo nell’ambito della recensione, ambito in cui ho sguazzato per almeno altrettanti anni di quelli trascorsi in biblioteca. La recensione (declinazione giornalistica del giudizio) è di fatto un consiglio (o sconsiglio) del recensore ai suoi lettori. Ovviamente il recensore non può condurre coi suoi lettori una conversazione per capire cosa questi realmente desiderino leggere. Nella recensione di fatto c’è un rapporto di potere che si configura come una comunicazione unidirezionale da uno a molti ma, non di meno, al di là dello stile di scrittura (e mi sia consentito qui ricordare le splendide recensioni di Antonio Tettamanti sul Mucchio Selvaggio, il cui stile ho sempre ammirato ben sapendo che per me sarebbe stato inarrivabile) la capacità del recensore di porsi – per dirla alla Ferrieri – nei panni, anzi nella pelle dei suoi lettori misura la differenza tra un recensore che vuole farsi capire ed un altro principalmente interessato all’osservazione del proprio ombelico. Per inciso questa argomentazione nel mio saggio di tanto tempo fa costituiva una premessa per cercare di trovare un modo per definire cosa sia arte e chi eventualmente possa riconoscere all’opera d’arte il suo status (e la risposta data allora – su cui anche oggi resto sostanzialmente d’accordo – è il tempo: le opere che sopravvivono al tempo sono opere d’arte – perché sanno parlare oltre la contemporaneità – e quella del critico è non un’assegnazione di titolo d’artisticità, quanto una scommessa, sulla base del proprio gusto affinato e delle proprie competenze estetiche, su quanto riuscirà a sopravvivere al proprio tempo). In realtà questo discorso non ci allontana troppo dal soggetto del libro di Ferrieri – il Readers’ Advisory Service – perché il nostro tempo sta assistendo alla crescita di un fenomeno interessante: quello dei/delle booktuber/booktoker e in generale creatori e creatrici di contenuti sulle piattaforme social che si occupano di libri e che paiono essere diventati un asset importante per l’industria editoriale (per dire: booktuber che fanno visualizzazioni analoghe a quelle di questo blog – e quindi non molte – ricevono i libri direttamente dalle case editrici). Essendo stato insignito dell’onere di curare la sezione “Young Adult” della biblioteca (ovviamente non grazie all’età affine ma per la passione per media e generi considerati vicini a questa fascia come fumetti e fantasy/fantascienza) mi sono “iscritto” a diversi canali di booktuber su YouTube esattamente per avere indicazioni e consigli su quali opere mettere a disposizione nella sezione. Mediamente i/le booktuber sembrano non avere riflettuto sul concetto di “consiglio” e al massimo hanno l’ipocrita cautela di affermare che i giudizi che esprimono sono esclusivamente giudizi personali. Cautela ipocrita perché poi i giudizi effettivamente espressi non hanno assolutamente la forma di giudizi personali (non “mi piace/non mi piace” ma “è bello/è brutto”). In coda al mio elenco dei libri letti nel 2023 è possibile vedere un esempio di questo atteggiamento da parte di una booktuber nota e con tante visualizzazioni: Ilenia Zodiaco. Nonostante questa evidente mancanza di approfondimento del “prodotto” che propongono, è indubbio che si tratta di un canale di promozione interessante e non è un caso che diverse biblioteche – purtroppo senza un’apprezzabile continuità – lo abbiano sperimentato. Anche qui non basta entusiasmo e spontaneità: occorrono tecnologie e competenze adeguate. Ma si tratta di un’attività che le biblioteche potrebbero realizzare molto meglio di molti influencer e content creator proprio perché se mancano (ancora) le competenze sul mezzo, le competenze sul contenuto e su come proporre tale contenuto come servizio sono sicuramente più elevate.
3. LA BIBLIOTECA CHE VERRÀ
Anche La biblioteca dei consigli si chiude con l’auspicio e la “predizione” sull’evoluzione della biblioteca:
L’esperienza americana dei RAS ci ha lasciato in eredità l’idea di un “servizio integrato” di consiglio. Integrato […] perché spazia da un libro a un film, da un quadro a una musica e a molto altro. Ma integrato, ancor di più e meglio, perché radicato nella diversità e nella inclusione dei pubblici, dei bisogni dei desideri. Perché risponde a un intreccio sempre più fitto di ruoli tra chi legge, chi scrive, chi produce: la creazione di contenuti da che la rete è rete non è più appannaggio esclusivamente autoriale, e la fruizione non è solo ricezione, ma i giochi si sono fatti sempre più incrociati. E l’integrazione, infine, richiede uno scambio anche all’interno della cosiddetta filiera commerciale: a produrre consigli non saranno solo i professionisti, i critici, i recensori o gli addetti ai lavori; a pubblicare libri e contenuti non saranno più solo gli editori; la lettura e il consiglio di lettura saranno sempre più il frutto di processi partecipati. Di qui la dimensione globalmente “integrata” e “inclusiva” di un servizio di consiglio che si fonda sull’alternanza di ruoli (tra autore, lettore, bibliotecario) e sulla condivisione di contenuti. (p. 281-282)
e
L’impegno consapevole, competente e coordinato di una rete di bibliotecari, librai, lettori e professionisti dell’informazione editoriale farà la differenza tra un processo abbandonato al caso e agli interessi economici e uno governato da progettualità, responsabilità e passione. Naturalmente ciò non potrà avvenire se non in forma cooperativa, anzi simbiotica, in cui ognuno dovrà fare la sua parte, con la consapevolezza, però, che nessuna parte è predeterminata e che andiamo verso un’epoca in cui i ruoli delle agenzie che si occupano di libri e lettura andranno profondamente ripensati e rimescolati. Molti confini saranno abbattuti. Molte cose che oggi fa la scuola le faranno anche le biblioteche, ma in accordo e collaborazione, non in supplenza e competizione. Avremo biblioteche o librerie che pubblicano libri e editori che catalogano e si occupano di metadatazione (con eliminazione di molti doppioni e sprechi). Più probabilmente questo diventerà un lavoro di tutti, come una “taggatura” di massa supervisionata. Per non dire delle trasformazioni riguardanti la figura dell’autore e il concetto di autorialità. (p. 286-287)
In questo meraviglioso mondo nuovo preconizzato da Ferrieri occorre però arrivarci, e forse un primo passo potrebbe essere proprio il riuscire a far dialogare le biblioteche con i content creator, forgiando un’alleanza che sarebbe proficua per entrambi i soggetti. Del resto, se lo fanno gli editori, che cos’hanno da perdere le biblioteche?

Link presenti nel testo:
mio post su La biblioteca che verrà: https://ossessionicontaminazioni.blogspot.com/2020/06/la-biblioteca-che-verra-qualche.html
link a Editrice Bibliografica: https://www.editricebibliografica.it/scheda-libro/luca-ferrieri/la-biblioteca-dei-consigli-9788893575669-581213.html
AIB-CUR: https://www.aib.it/attivita/aib-cur/
Codice deontologico dei bibliotecari: https://www.aib.it/documenti/codice-deontologico/
Neal Wyatt e Joyce G. Saricks, The Readers’ Advisory Guide to Genre Fiction: https://alastore.ala.org/content/readers-advisory-guide-genre-fiction-third-edition
Diana Tixier Herald e Samuel Stavole-Carter, Genreflecting. A Guide to Popular Reading Interests: https://www.bloomsbury.com/us/genreflecting-9781440858475/
Wichbook: https://www.whichbook.net
LiBeR Database: https://www.liberweb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20007&Itemid=213
Opac del Polo bibliotecario piacentino: https://leggerepiace.it/SebinaOpac/.do. Per fare una ricerca per parole chiave occorre andare su Ricerca avanzata e selezionare nel menu il campo di ricerca Parola chiave (è l’ultima voce). Le parole chiave sono utilizzate solo per i libri di narrativa per ragazzi quindi non dovrebbe uscire nei risultati rumore costituito da libri per il pubblico adulto.
Il mio giudizio su Snow Crash: https://ossessionicontaminazioni.com/2024/03/17/snow-crash-riletto/
Elenco dei libri letti nel 2023 con – alla fine – critica del giudizio non personale di una booktuber: https://ossessionicontaminazioni.com/2024/01/01/libri-letti-nel-2023/
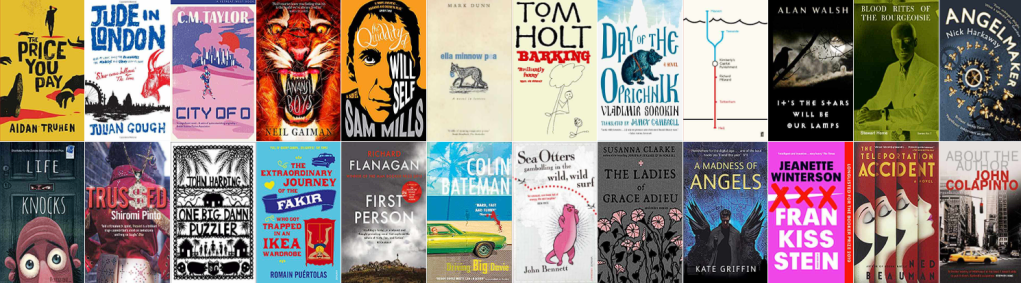
Lascia un commento