COME HO CONOSCIUTO WATZLAWICK
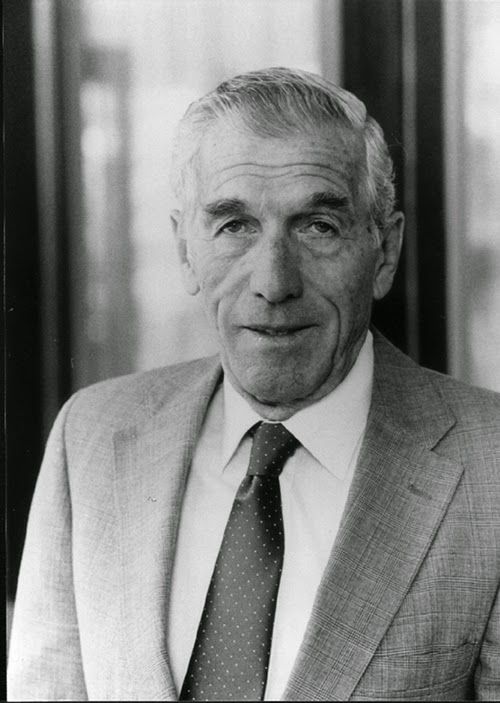
Allo scorso Book Pride, presso lo stand della Casa Editrice Astrolabio, ho acquistato un libro di Paul Watzlawick che ancora non avevo. Paul Watzlawick è un autore estremamente importante per la mia formazione (data la lunghezza di questo post, per un profilo dell’autore rimando alla sua scheda su Wikipedia). L’ho incontrato per la prima volta all’interno del programma dell’esame di Pedagogia all’Università. All’interno del testo Educazione come sistema del docente, il Prof. Sergio De Giacinto (ho narrato il mio incontro/scontro con questo docente in un post sul libro di Robert Pirsig Sulla qualità), la premessa fondamentale erano i cinque assiomi della comunicazione esposti nel testo fondamentale Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei modelli interattivi delle patologie e dei paradossi di Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin e Don D. Jackson, pubblicato originariamente nel 1967 e in traduzione italiana nel 1971 da Astrolabio. I tre autori erano all’epoca i tre principali ricercatori del Mental Research Institute di Palo Alto in California e riprendevano e proseguivano gli studi di Milton Erickson e soprattutto del concetto di “doppio legame” analizzato da Gregory Bateson. Estremamente importanti per l’enucleazione degli assiomi sopra citati sono stati anche gli studi di Ronald D. Laing, psichiatra scozzese che studiava la schizofrenia all’interno della prestigiosa Tavistock Clinic di Londra e che ha pubblicato opere fondamentali come L’io diviso, Normalità e follia nella famiglia (con A. Esterson) e Nodi (solo per citarne i tre forse più famosi, di cui il primo e il terzo sono ancora disponibili a catalogo da Einaudi). Le opere di Laing, assieme a quelle di altri autori appartenenti alla “anti-psichiatria” (come David Cooper, l’esponente forse più apertamente politico) le avevo studiate assai bene per una tesina per il corso di Storia delle dottrine politiche. Non ricordo se in occasione di un compleanno, miei amici mi regalarono – forse anche un po’ per prendersi gioco della mia americanofilia (soprattutto musicale) – un suo libro appena uscito: America: Istruzioni per l’uso (Feltrinelli, 1985) e io acquistai e lessi il successivo Istruzioni per rendersi infelici (Feltrinelli, 1988). Acquistai poi anche Change. Sulla formazione e la soluzione dei problemi scritto in collaborazione con John H. Weakland e Richard Fisch (Astrolabio, 1974) che però era rimasto fino ad ora in libreria. Ma essendo arrivato a raggiungerlo La realtà della realtà. Comunicazione, disinformazione, confusione (Astrolabio, 1976) ho deciso fosse il momento di riprendere Pragmatica e di leggere i due libri non ancora letti. Anche perché, pur essendo scritti cinquant’anni fa, ancora riescono a dirci cose estremamente importanti non solo sul nostro disagio psicologico e sociale, ma anche sulla drammatica situazione internazionale che stiamo vivendo. In più, proprio sull’ultimo acquistato, c’è una riflessione sull’uomo nel tempo che non posso tralasciare, essendo stata oggetto già di diversi miei post.
I CINQUE ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE
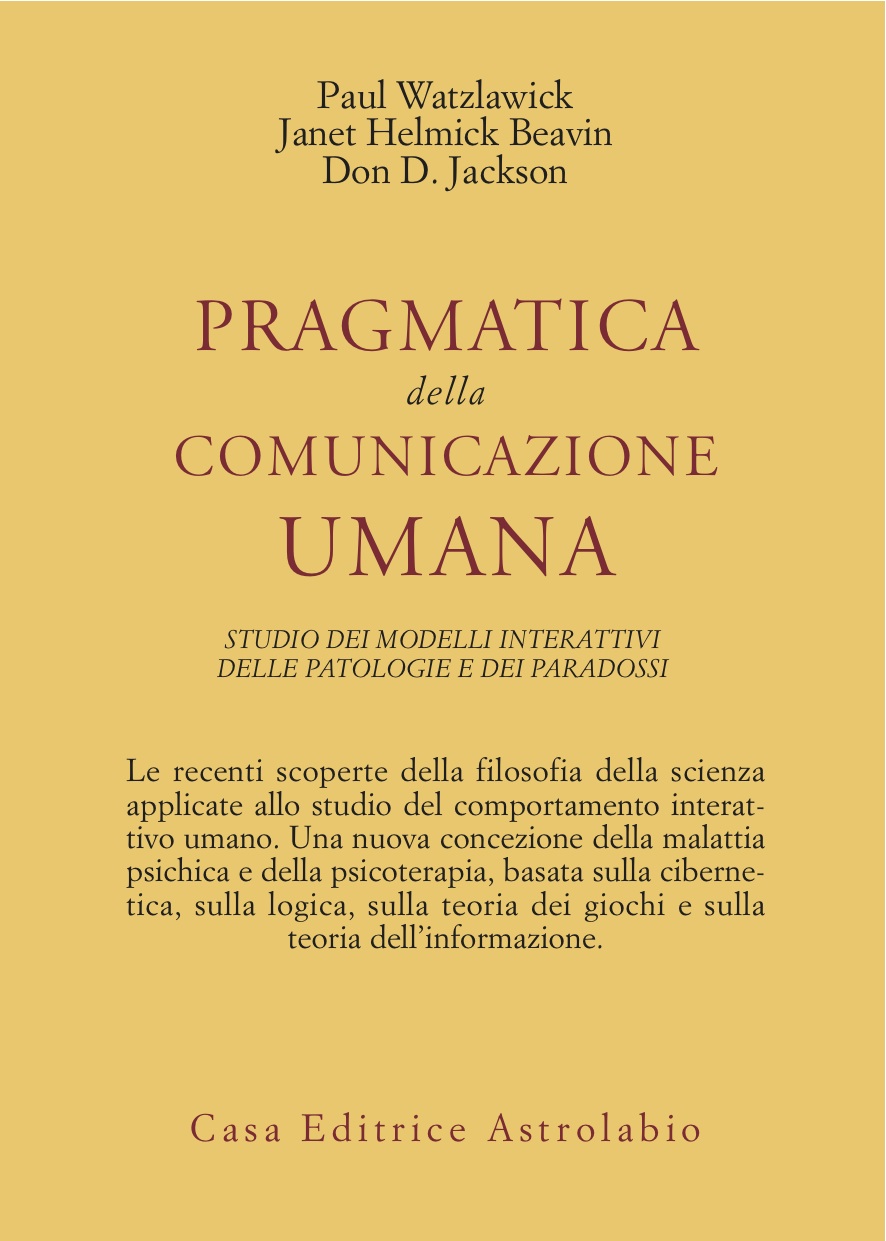
Per parlare di Change e di La realtà della realtà occorre, almeno per chi non abbia mai affrontato lo studio della comunicazione in ambito psicologico/psichiatrico, una introduzione agli assiomi della comunicazione esplicitati in Pragmatica della comunicazione umana. E per farlo occorre anche accennare ai lavori di Bateson e di Laing sulla schizofrenia. Il concetto chiave formulato da Bateson per spiegare la genesi della schizofrenia è quello del “doppio legame”. Per esporre questo concetto riprendiamo l’esauriente spiegazione riportata da Wikipedia:
Il doppio legame indica una situazione in cui la comunicazione tra due individui, uniti da una relazione emotivamente rilevante, presenta una incongruenza tra il livello verbale (quello che viene detto a parole) e quello non verbale (gesti, atteggiamenti, tono di voce, ecc.), e la situazione sia tale per cui il ricevente del messaggio non abbia la possibilità di sottrarsi a questo schema stabilito dal messaggio, o metacomunicando o chiudendosi in se stesso.
Come esempio Bateson riporta l’episodio della madre che dopo un lungo periodo rivede il figlio, ricoverato per disturbi mentali. Il figlio, in un gesto d’affetto, tenta di abbracciare la madre, la quale si irrigidisce; il figlio a questo punto si ritrae, al che la madre gli dice: “Non devi aver paura di esprimere i tuoi sentimenti” o “Sii spontaneo!”. A livello di comunicazione implicita (il gesto di irrigidimento) la madre esprime rifiuto per il gesto d’affetto del figlio, invece a livello di comunicazione esplicita (la frase detta in seguito), la madre nega di essere la responsabile dell’allontanamento, alludendo al fatto che il figlio si sia ritratto non perché intimorito dall’irrigidimento della madre, ma perché bloccato dai suoi stessi sentimenti; il figlio, colpevolizzato, si trova impossibilitato a rispondere.
A partire da questo concetto si sviluppano i lavori di Laing e in particolare Normalità e follia nella famiglia (del 1964) dove espone i casi di pazienti ricoverate con la diagnosi di schizofrenia dove immancabilmente viene sottolineato come il disagio mentale sia fatto esplodere da una situazione familiare intessuta da siffatte situazioni paradossali. Arriviamo così a Pragmatica della comunicazione umana dove Watzlawick e colleghi, forti sia delle ricerche richiamate sia del loro stesso lavoro in ambito psichiatrico, giungono a formulare i cinque assiomi che sostengono la comunicazione:
non si può non comunicare (p. 44) [essendo la comunicazione un’attività sociale che prevede almeno una emittente e almeno una ricevente anche la mancanza di comunicazione – esplicita – è una comunicazione – implicita -];
Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e un aspetto di relazione di modo che il secondo classifica il primo ed è quindi metacomunicazione (p. 47) [in genere l’aspetto di contenuto è di tipo verbale e l’aspetto di relazione veicolato dal comportamento non verbale; ad esempio se dico sorridendo “sei uno stupido”, la comunicazione a livello di contenuto è offensiva ma a livello di relazione è scherzosa];
la natura di una relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione tra i comunicanti (p. 52) [quando due persone litigano normalmente ognuno riassume la nascita della discordia “punteggiando” la situazione a scapito dell’altro, ad esempio: A è offeso perché B non lo ha chiamato; B non ha chiamato A perché A è taciturno e temeva di disturbarlo; A è taciturno perché B lo tratta con distacco; B lo tratta con distacco perché non riesce a capire come comportarsi con A senza che lui si offenda, ecc.];
Gli esseri umani comunicano sia con il modulo numerico che con quello analogico. Il linguaggio numerico ha una sintassi logica assai complessa e di estrema efficacia ma manca di una semantica adeguata nel settore della relazione, mentre il linguaggio analogico ha la semantica ma non ha alcuna sintassi adeguata per definire in un modo che non sia ambiguo la natura delle relazioni (p. 59) [normalmente il modulo numerico è quello che trasmette l’aspetto di contenuto mentre quello analogico trasmette l’aspetto di relazione: un esempio è la comunicazione su internet o via email che manca dell’aspetto analogico e può quindi produrre ambiguità e fraintendimenti];
Tutti gli scambi di comunicazione sono simmetrici o complementari, a seconda che siano basati sull’uguaglianza o sulla differenza (p. 62) [uno scambio di comunicazione simmetrico si ha ad esempio in un litigio tra due coniugi quando entrambi non desistono dal far valere le proprie ragioni, mentre uno scambio di comunicazione complementare sia ha invece tra un genitore e un figlio o tra un ufficiale e un soldato].
Questi assiomi funzionano a qualsiasi livello della comunicazione umana: tanto a livello interpersonale, tanto a livello sociale (sia nel microsociale della famiglia, sia nel macrosociale della comunità urbana, regionale, nazionale e internazionale), tanto al macrolivello sociale legato alla dimensione politica. Pensiamo ad esempio ai due maggiori conflitti che come europei attualmente stiamo vivendo: il conflitto Russia-Ucraina e quello Israele-Palestina. Ad entrambi questi conflitti possono applicarsi perfettamente gli assiomi della comunicazione sopra riportati e, in particolare in maniera estremamente evidente il terzo relativo alla punteggiatura: sia i rispettivi stati sia chi al di fuori supporta la loro ragione sostiene che la causa sia da imputarsi all’altro stato, a cui gli stati e sostenitori antagonisti rispondono che tale causa menzionata non è la causa prima dato che alle sue spalle sta un’ulteriore causa generata dai primi, ma anche questa ulteriore causa avrebbe secondo i primi una ancora più ulteriore causa generata dai secondi, e così via fino a raggiungere motivazioni decisamente assurde (come l’assenza di palestinesi nel territorio di Israele ai tempi di Gesù per spiegare l’invasione e lappropriazioni di territori palestinesi – ad esempio in Cisgiordania – da parte degli israeliani).
PLUS ÇA CHANGE, PLUS C’EST LA MÊME CHOSE
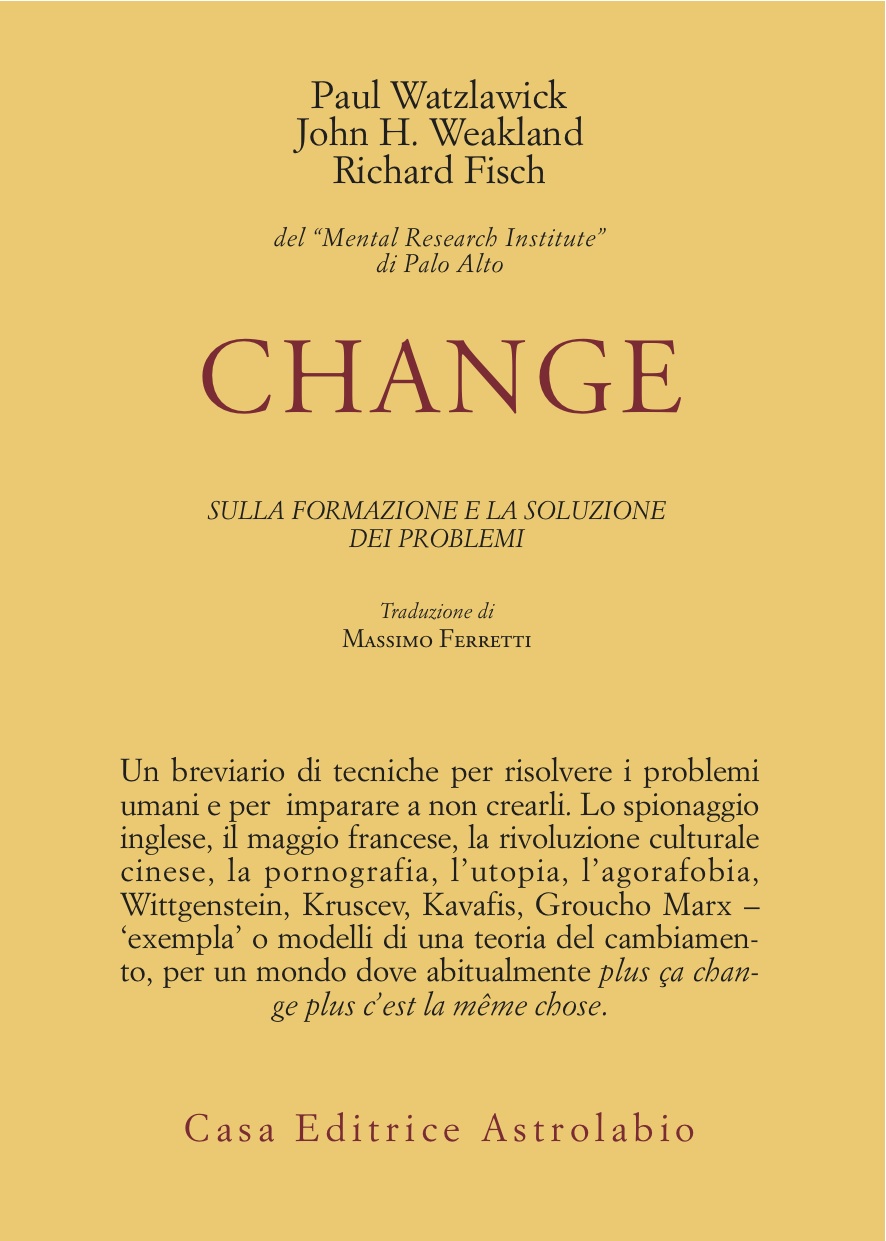
All’analisi delle disfunzioni della comunicazione che portano a follia (livello individuale), disordini (livello sociale) e guerre (livello politico) cerca di offrire una soluzione Change, che contemporaneamente è la parola inglese e la corrispettiva parola francese di cui si riporta in apertura di libro il motto francese posto a titolo di questa parte. Motto che viene usato per indicare come spesso gli sforzi fatti per cambiare una situazione non abbiano alcun effetto se non quello di esacerbare e approfondire i problemi che cercano di risolvere. Esemplificando, se abbiamo una persona con un problema di ansia, cercando di tranquillizzarla potremo ottenere il risultato opposto, cioè di aumentare l’ansia perché il tentativo di tranquillizzazione viene visto come un tentativo di nascondere la causa dell’ansia e, in quanto tale, giustifica esattamente quella sensazione; in tale situazione ogni sforzo per convincere il soggetto che non ha motivo di essere ansioso ottiene esattamente il risultato di aumentarne l’ansia e di aggravare il problema (cioè: più le cose cambiano, più restano le stesse). Cambiare le situazioni problematiche, ci spiegano Watzlawick e colleghi in questo libro, è impossibile a meno che non ci si renda conto dei due livelli di comunicazione implicati in qualsiasi paradosso comunicativo e non si impari ad agire non a livello comunicativo di base (cosa che normalmente porta al conflitto che abbiamo visto esemplificato relativamente al terzo assioma) ma a livello meta-comunicativo. Uscendo dagli schemi concettuali che dominano la comunicazione e portando la comunicazione ad un livello superiore che permetta di ristrutturare il problema in altri termini. Questo viene reso possibile utilizzando sui problemi le teorie dei gruppi e dei tipi logici. Non starò qui ad allungare l’esposizione riassumendo in dettaglio tali teorie e l’utilizzo che Watzlawick e colleghi hanno applicato ai casi che si presentavano loro per poi esporli nel testo. Criticando esplicitamente terapie che si allungano a dismisura, che apparentemente non hanno fine, e sostenendo una approccio terapeutico breve che non vada ad indagare le cause, quanto si proponga di risolvere le situazioni problematiche per cui i pazienti si rivolgono loro. Conoscere le cause secondo gli autori infatti potrebbe essere a sua volta causa del problema dato che le cause costituiscono una realtà che il paziente si costruisce per autogiustificarsi. Ecco allora che le soluzioni che propongono ai loro pazienti sono controintuitive e paradossali e funzionano nella misura in cui passano dal livello comunicativo a quello metacomunicativo. Riporterò qui di seguito un esempio di terapia tratto dal libro che servirà anche per traghettarci al libro successivo:
Una donna intelligente, abituata a prendere da sola le proprie decisioni – con una lunga esperienza di segretaria di direzione – incontrava difficoltà con uno dei suoi dirigenti. A giudicare dalla descrizione che ci fece del conflitto, quest’uomo sembrava irritato e reso insicuro dal suo modus operandi indipendente e piuttosto aggressivo a cui lui reagiva non perdendo occasione di umiliarla soprattutto davanti agli altri. La donna ne era tanto offesa che spesso lo trattava con un distacco e un sussiego ancor più accentuati – un atteggiamento a cui l’uomo reagiva sminuendola più di prima, cioè inasprendo il comportamento che all’inizio l’aveva fatta arrabbiare. La situazione precipitò tanto che l’uomo sembrava sul punto di proporre il trasferimento o il licenziamento della donna, mentre lei era quasi decisa a dargli pan per focaccia dimettendosi subito.
Senza spiegarle il perché le impartimmo le seguenti istruzioni. Doveva aspettare la prossima scenata e poi approfittar della prima occasione per prendere il direttore a quattr’occhi e fargli, con malcelato imbarazzo, un discorsetto più o meno come questo: “È da tanto tempo che volevo dirglielo, ma non sono mai riuscita a trovare le parole… È una follia… ma quando mi tratta come ha fatto prima, mi sento rimescolare tutta… È un turbamento che mi sfugge, non so spiegarmelo… Forse c’entra mio padre…”; subito dopo doveva uscire alla svelta dalla stanza prima che lui potesse dire una parola.
In un primo momento l’idea le fece orrore, poi la interessò molto, infine la trovò estremamente buffa e disse che non vedeva l’ora di fare questo esperimento. Ma quando ritornò da noi ci raccontò che proprio il mattino dopo quella seduta il comportamento del direttore era improvvisamente cambiato e che da quel momento era stato educato e conciliante.
Se ci fosse bisogno di una prova che la realtà è ciò che abbiamo convenuto di chiamare “realtà”, tale forma di cambiamento potrebbe fornircela. A rigor di termini, nulla era “veramente” cambiato nel senso che non c’era stata tra quelle due persone nessuna comunicazione o azione esplicita. Ma a rendere efficace questa forma di soluzione dei problemi è il fatto che l’interessato sappia di poter ora affrontare in modo diverso una situazione che in precedenza gli sembrava minacciosa. Il cambiamento che provoca nel comportamento del soggetto viene trasmesso attraverso i canali della comunicazione umana, che sono molteplici e assai sottili – un cambiamento che incide sulla realtà interpersonale nella forma desiderata anche se il comportamento prescritto non è mai stato effettivamente adottato. […]
Lo spunto per definire “Bellac ploy” tale tipo di intervento ce lo ha dato una commedia di Jean Giraudoux intitolata L’Apollon de Bellac. Una ragazza timida, Agnès, aspetta con apprensione di essere ricevuta dal presidente di una società per un colloquio da cui dipende la sua assunzione. Nell’anticamera c’è pure un giovanotto, a cui la ragazza confida i suoi timori, il quale sostiene che il modo più semplice di trattare la gente è quello di dire ai propri interlocutori che sono avvenenti. Anche se in un primo momento la ragazza è scandalizzata dall’apparente insincerità di questo consiglio, il giovane riesce a convincerla che basta dire a una persona che è avvenente per renderla tale e che quindi non è affatto insincero dirglielo. Agnès segue il consiglio e riesce subito a conquistare la simpatia di un uomo burbero come l’impiegato, di una persona arrogante come il vicepresidente, e poi anche quella dei direttori. Infine, il presidente si precipita fuori del suo ufficio e dice:
Signorina Agnès, sono quindici anni che questa organizzazione è immersa nel malumore, nella gelosia e nel sospetto. E questa mattina, all’improvviso, è cambiato tutto. L’impiegato, che di solito è una jena, [l’impiegato sorride affabilmente] è diventato così affabile da inchinarsi persino all’ombra che stampa sul muro. [L’impiegato contempla la propria silhouette d’ombra che si staglia nella luce del sole e fa un cenno di approvazione. L’ombra restituisce il cenno del capo.] Il primo vicepresidente – che ha la fama, finora mai smentita, di essere una persona alquanto ligia ad ogni tipo di formalità – vuol sedersi a ogni costo alla riunione dei direttori in maniche di camicia. Dio sa perché…
[…]
La situazione rappresentata da Giraudeaux va collocata al polo opposto di quei grovigli interpersonali e autoperpetuantisi in cui la bruttezza genera bruttezza nell’altro e poi retroagisce su se stessa. Ma Giraudeaux mostra anche – benché lo faccia, grazie alla licenza poetica del commediografo, per semplificare al massimo – che un cambiamento iniziale molto piccolo può bastare a cambiare l’intero sistema. (p. 137-139)
In questo esempio è possibile vedere perfettamente come il problema generato dalla rispettiva incomprensione si dissolve quasi miracolosamente grazie al semplice cambio di atteggiamento. Così come nella storia di Agnès è sufficiente mettere a proprio agio gli altri per creare un clima sereno. Per questo Watzlawick e colleghi ci mostrano come la realtà che crediamo di percepire è in realtà una realtà costruita a livello di comunicazione sia individuale che collettiva. La realtà è quella che crediamo che sia. E questo ci porta all’ultimo libro.
LA REALTÀ DELLA REALTÀ
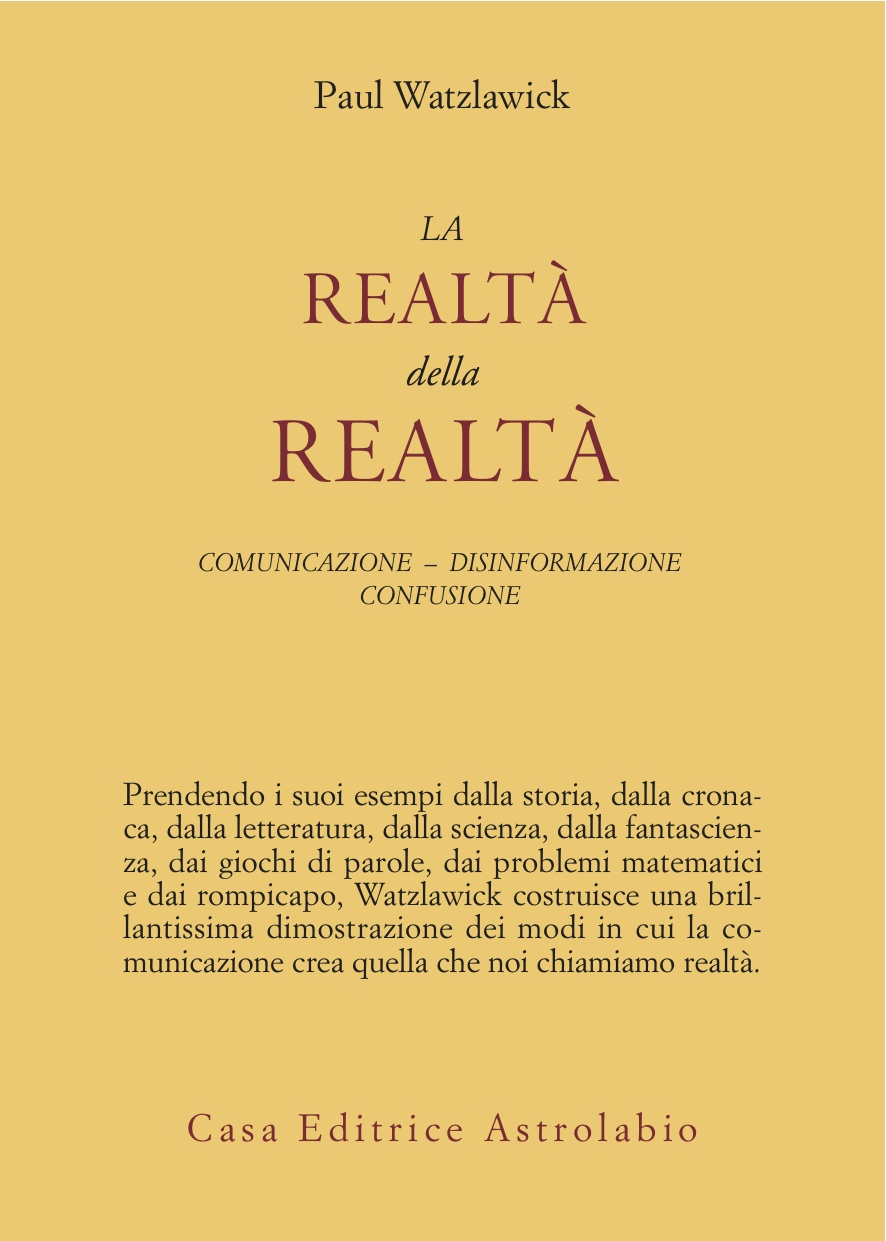
Arriviamo così a parlare infine di La realtà della realtà. Watzlawick chiarisce fin dall’inizio il punto essenziale da cui prende le mosse:
Quest’opera si occupa del modo in cui la comunicazione crea quella che noi chiamiamo realtà. […] Come dimostreremo, le nostre idee tradizionali sulla realtà sono illusioni che andiamo accumulando per la maggior parte della nostra vita quotidiana, anche al rischio notevole di cercar di costringere i fatti ad adattarsi alla nostra definizione della realtà, e non viceversa. Ma l’illusione più pericolosa è che esista soltanto un’unica realtà. In effetti esistono molte versioni diverse della realtà, alcune contraddittorie, ma tutte risultanti dalla comunicazione e non riflessi di verità oggettive, eterne. (p. 7)
Nel libro l’autore mostra svariate modalità di costruzioni erronee di realtà tramite comunicazioni erronee, disinformazione e confusione, a volte involontarie, a volte invece volontarie, come ad esempio nel mondo dello spionaggio (il libro è del 1976, epoca di guerra fredda combattuta attraverso i servizi segreti). Inevitabile l’esame del caso dei Protocolli dei Savi di Sion che, nonostante l’evidente falsità, hanno contribuito a creare il clima di odio nei confronti degli ebrei che è sfociato nelle leggi razziali italiane e tedesche e nella “soluzione finale” nazista.
Ma il libro cerca anche ad indagare quali potrebbero essere i canali comunicativi da attivare per comunicare con specie diverse (le scimmie e i delfini) o con ipotetici alieni extraterrestri. Watzlawick esamina i tentativi fino ad allora compiuti e i risultati, molto interessanti anche se non pienamente soddisfacenti. E, in conclusione, approccia la dicotomia libertà vs. determinismo. Vi arriva naturalmente da un nodo comunicativo, un paradosso: il paradosso di Newcomb.
L’importanza principale di questo paradosso per l’argomento di quest’opera nasce dal contesto su cui si basa; un contesto di comunicazione con un Essere che ha la capacità di predire le scelte umane con una precisione quasi totale. Ecco come Nozick definisce la capacità dell’Essere (e al lettore si raccomanda di prestare attenzione alla definizione, dal momento che è indispensabile per la comprensione di quanto seguirà): “Sapete che questo Essere ha spesso predetto correttamente le vostre scelte nel passato (e non ha mai fatto, per quanto ne sapete, una predizione scorretta sulle vostre scelte), e inoltre sapete che questo Essere ha spesso predetto correttamente le scelte di altre persone, di cui molte sono simili a voi, nella situazione particolare che verrà descritta qui di seguito”. Notate che ciò rende le predizioni dell’Essere quasi, ma soltanto quasi, totalmente attendibili.
L’Essere vi mostra due scatole, e spiega che la scatola numero 1 contiene mille dollari mentre la scatola numero 2 contiene o un milione di dollari o nulla. Potete decidere in base a due scelte: 1) prendere ciò che è in ambedue le scatole; 2) prendere soltanto ciò che è nella seconda scatola. L’essere ha disposto i seguenti risultati: se scegliete l’alternativa 1 e prendete il contenuto di ambedue le scatole, l’Essere (prevedendo ciò) lascerà vuota la scatola numero 2; riceverete quindi soltanto i mille dollari della scatola numero 1. Se decidete di prendere soltanto la scatola numero 2, l’Essere (prevedendo questo) vi metterà dentro il milione di dollari. Notate per favore che la sequenza di eventi si svolge così: l’Essere fa la sua predizione, poi (in base alla sua predizione sulla vostra scelta) mette o no il milione di dollari nella scatola numero 2, poi comunica a voi le condizioni, e allora voi fate la vostra scelta. (p. 186-187).
In questione in questo paradosso è il libero arbitrio, la possibilità reale di scelta da parte dell’essere umano perché, se la predizione è esclusivamente una scommessa basata eventualmente su un’analisi statistica, allora la scelta migliore sarebbe quella di prendere entrambe le scatole e sperare che stavolta l’Essere si sia sbagliato accaparrandoci un milione più mille dollari ed evitando nel contempo il possibile errore alternativo di prendere solo la seconda scatola per trovarla vuota. Se invece ci muoviamo in una dimensione deterministica che esclude la libera scelta, allora l’Essere evidentemente conoscerà esattamente l’esito della nostra scelta e la scelta stessa non avrebbe alcun senso. L’analisi della dicotomia porta Watzlawick a considerare l’essere umano nella dimensione temporale che viene normalmente considerata una catena di cause ed effetti (e che in quanto tale escluderebbe la libertà della scelta) e sceglie una metafora che anch’io avevo già utilizzato: quella del film che possiamo riavvolgere e rivedere dall’inizio o andare avanti veloce per vedere in anticipo la conclusione. Questo lo conduce ad esaminare l’ipotesi dei viaggi nel tempo ed i possibili paradossi che producono, ma non ad esporre una propria soluzione alla dicotomia tra libero e servo arbitrio. In particolare a p. 201 riflette:
Ah, se solo potessimo viaggiare nel futuro e vedere coi nostri occhi! Ma aspettate: che differenza farebbe? Se tutte le nostre azioni e tutti i loro risultati sono già registrati sul film, la nostra preconoscenza di questi risultati non li cambierebbe affatto; saremmo nella posizione orribile di dover fare le stesse precise scelte che ora sappiamo saranno sbagliate e dannose per noi o per gli altri. Non preferiremmo forse ritornare al nostro misericordioso stato d’ignoranza? Che inferno sarebbe la vita se, ad esempio, sapessimo la data e le circostanze della nostra morte!
Qui Watzlawick – nonostante citi diversi autori di fantascienza che trattano di viaggi del tempo come Isaac Asimov e Fredric Brown) – dimostra colpevolmente di non conoscere Mattatoio n. 5 di Kurt Vonnegut (pubblicato nel 1969) che tratta esattamente di questa tematica. Il suo protagonista, Billy Pilgrim sa esattamente la data e le circostanze della sua morte ma questo, ben lungi dall’atterrirlo, lo spinge a riempire al meglio la vita nella consapevolezza che il tempo come freccia unidirezionale è solo il modo in cui la nostra coscienza esperisce il mondo che in sé è un tutto privo di passato/presente/futuro. In questo modo ho interpretato anche il concetto nietzscheano di “eterno ritorno dell’identico”: non un ciclo di ripetizioni ma un tutto in cui solo la nostra coscienza limitata vede come un’inesorabile progressione verso la morte. In questo contesto entra anche il concetto heideggeriano di “essere per la morte”, che si aggancia bene alla riflessione watzlawickiana sopra citata e che, in ottica nietzscheana e vonnegutiana, preferisco ribaltare in “essere per la vita” (anche se in una dimensione immanente piuttosto che nell’interpretazione religiosa di una vita oltre la vita terrena): tutti moriremo – per citare Vonnegut: così è la vita – ma non ha importanza come moriremo, l’importante è esaltare tutte le piccole cose, apparentemente insignificanti, che incontriamo all’interno della nostra vita. Su questo argomento ho già pubblicato diversi post e lascio il link nella sezione finale.
Concludo richiamando la necessità di migliorare la nostra competenza comunicativa, unico elemento che ci permette di risolvere problemi e conflitti interpersonali e sociali. Poi non sono in grado di capire qual è la dimensione metacomunicativa che potrebbe aiutare a risolvere i conflitti in corso citati all’inizio, ma la speranza è che i mediatori non lavorino solo a livello di comunicazione base, che cambiano le cose solo per lasciarle immutate, ma che riescano a inquadrare il problema da una prospettiva superiore e a proporre soluzioni concrete e definitive (prima che la situazione degeneri in un conflitto globale).
Link nel post:
i libri di Watzlawick pubblicati da Astrolabio: http://www.astrolabio-ubaldini.com/ricerca?q=watzlawick
scheda di Paul Watzlawick su Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick
il corso di Pedagogia: https://ossessionicontaminazioni.blogspot.com/2024/03/la-mia-vita-dopo-robert-m-pirsig.html
il concetto di “doppio legame” spiegato su Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Doppio_legame_(psicologia)
L’io tra identità e differenza (o della filosofia spiegata coi videogiochi) (2019): https://ossessionicontaminazioni.blogspot.com/2019/11/lio-tra-identita-e-differenza-o-della.html
Temporalità di Heidegger e Attualismo di Gentile (2020): https://ossessionicontaminazioni.blogspot.com/2020/12/temporalita-di-heidegger-e-attualismo.html
Sull’eterno ritorno dell’identico (2022): https://ossessionicontaminazioni.blogspot.com/2022/05/sulleterno-ritorno-dellidentico.html
Vonnegut a fumetti (2022): https://ossessionicontaminazioni.com/2022/11/24/vonnegut-a-fumetti/
La realtà, il tempo e le ombre oscure di Providence (2023): https://ilmanifesto.it/la-realta-il-tempo-e-le-ombre-oscure-di-providence

Lascia un commento