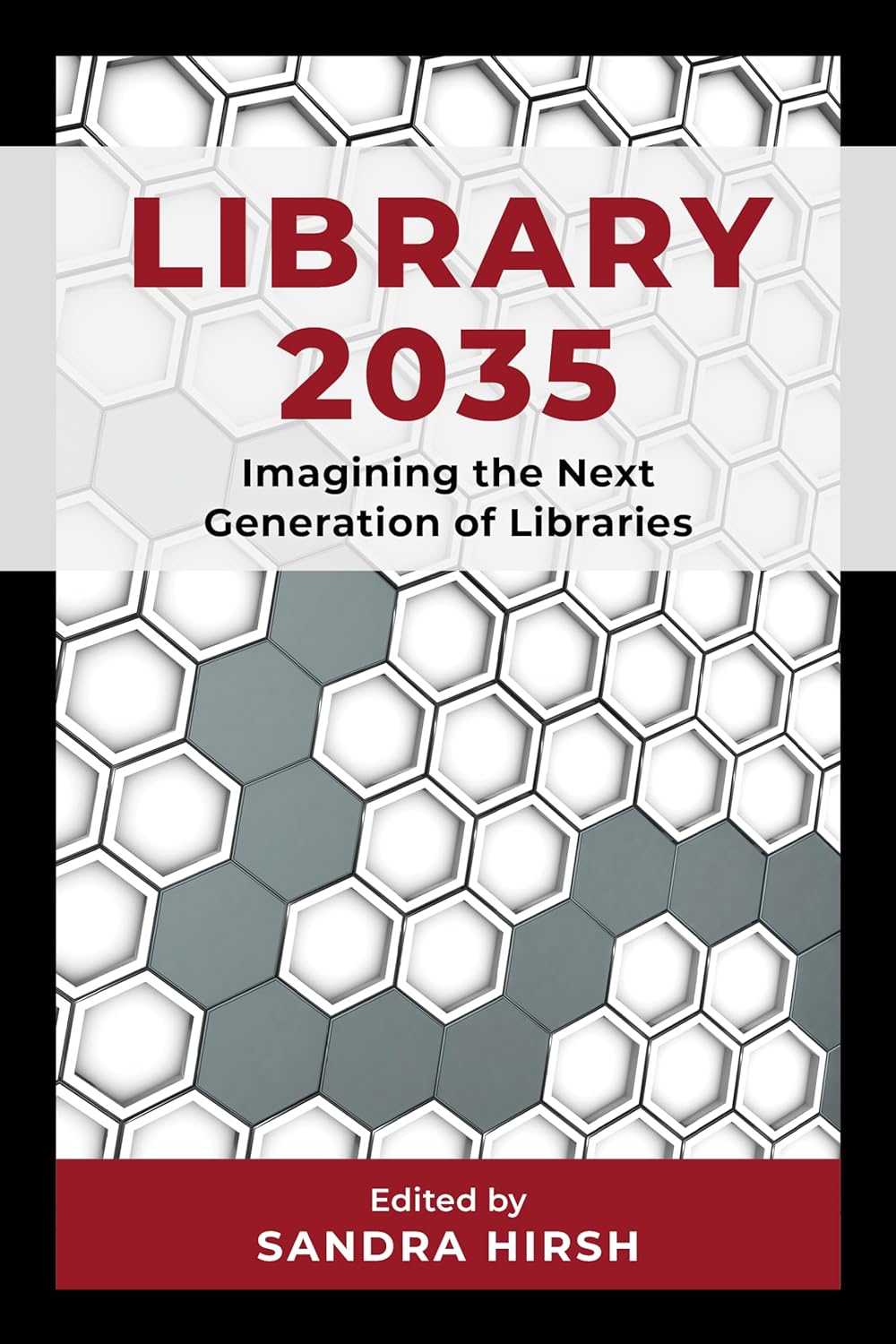
L’appena pubblicato Library 2035: Imagining the Next Generation of Libraries, curato da Sandra Hirsh e pubblicato da Rowman & Littlefield, mi ha lasciato perplesso. In primo luogo perché il metodo adottato dagli autori di cui il testo contiene il contributo (direttori di biblioteche, presidenti di associazioni bibliotecarie, docenti di LIS – tra cui R. David Lankes) non applicano al compito proposto il metodo segnalato da Jane McGonigal e dall’Institute For The Future (di cui ho scritto in questo post), per quanto l’IFTF sia pure richiamato in un intervento, cioè quello di non cercare di individuare le correnti del cambiamento in atto ma piuttosto di immaginare se stessi 10 anni avanti nel futuro cercando di descrivere i cambiamenti che si trovano di fronte rispetto al passato. Al contrario, non straordinariamente, buona parte degli interventi in Library 2035 sono un’auto-celebrazione degli autori che descrivono quali sono state le innovazioni che hanno introdotto negli anni passati e come queste avranno (secondo loro) importanza anche nel prevedibile futuro. Ma quello che maggiormente mi ha colpito è la quasi totale assenza di interventi dedicati all’evoluzione dello sviluppo delle collezioni e della catalogazione (tranne un intervento dedicato alla necessità di sviluppare alleanze da parte delle biblioteche accademiche per poter acquisire i periodici accademici ed offrire l’accesso a tutti gli studenti e ricercatori delle istituzioni associate). In quasi tutti gli interventi viene individuato come fattore di cambiamento la comparsa dell’Intelligenza Artificiale, la necessità che le biblioteche di qualsiasi tipologia siano attente alla diversità e alla tutela ambientale e contrastino gli episodi di intolleranza e razzismo, e da molti autori sono citati gli episodi di messa al bando di libri non graditi come elemento contro cui fare leva.
Forse ci sono solo due interventi che vanno nella direzione di immaginare effettivamente un futuro con elementi di rottura: Predictions About Future in Libraries and Epistemic Collapse: Laws and Models di Jason Griffey (direttore delle iniziative strategiche al National Information Standards Organization e in precedenza consulente tecnico per biblioteche e bibliotecario accademico all’Università del Tennessee) e Teetering on the Edge of Trust Cliff di Erin Berman (direttrice della Divisione Equitable Libraries della Alamenda County Library in California e già alla guida del sottocomitato della privacy di American Library Associations).
Griffey immagina che nel 2035 la produzione di narrativa, grazie alle IA, diventerà estremamente personalizzata e tendenzialmente sostituirà la pubblicazione di libri sia in formato cartaceo sia in formato elettronico. Ogni lettore chiederà all’IA una storia con le caratteristiche desiderate e la IA la produrrà “al volo”, personalizzata per il richiedente. Di fronte a questa innovazione il ruolo delle biblioteche diviene ovviamente problematico dato che si tratta di storie individualizzate non facilmente raccoglibili.
Berman invece focalizza l’attenzione sull’evoluzione della privacy che viene sempre più erosa dalle nuove applicazioni. Da questo punto di vista la biblioteca ha di fronte due scenari: offrire servizi avanzati che tuttavia siano progressivamente lesivi della privacy degli utenti e possono offrire il fianco ad attività censorie (ad esempio dei genitori sulle letture dei figli o degli amministratori sulle letture dei cittadini) provocando la perdita di fiducia da parte degli utenti; tutelare rigorosamente la privacy degli utenti anche al costo di limitare i servizi e potenzialmente di fare contro-promozione.
La menzionata attenzione in praticamente tutti gli interventi per l’inclusività degli spazi bibliotecari (in un intervento si raccomanda esplicitamente di togliere spazio agli scaffali e aumentare quello dedicato alla presenza di utenti) per la comunità di riferimento, per i diversi modi di essere (etnici, sessuali, religiosi, ecc.), l’essere sempre di più spazio di collaborazione per la comunità a scapito dell’investimento (in termini finanziari, di spazio, di risorse umane) sullo sviluppo delle collezioni e del loro trattamento, onestamente mi lascia un po’ perplesso. Tanto più che questo mette la biblioteca come istituzione in un ruolo apertamente politico che può, tanto più in questo periodo, andare a confrontarsi con un sentimento che viaggia in direzione diametralmente opposta e su cui, ad esempio, conta Trump per farsi rieleggere. La biblioteca focalizzata sulla collezione è in qualche modo meno a rischio di subire censure perché meno viene percepita da parte di una amministrazione non in linea col suo essere concretamente “istituto della democrazia” un pericolo alle proprie inclinazioni che vanno contro certe inclusività (contro l’inclusività agli immigrati, al popolo LGBTQI+, ecc.). Certo il rinchiudersi in posizioni di comodo che non sfidino derive politiche lesive di diritti sarebbe fin troppo comodo, ma chi non ci assicura che anche una porzione di bibliotecari/e non sia allineata con queste meno inclusive posizioni politiche? O che possa accettare di schierarsi apertamente con con i principi inclusivi della biblioteca a fronte di tagli di budget e/o ricollocamenti?
Le collezioni come core business non sono necessariamente in contrasto con la realizzazione di servizi inclusivi e se è prevedibile che operazioni algoritmiche come la catalogazione descrittiva possano essere automatizzate anche in tempi non troppo lunghi, è molto più improbabile, a mio modo di vedere, l’abbandono del libro, in particolare del libro stampato, da parte dello zoccolo duro di lettori e lettrici che ne hanno un attaccamento quasi feticistico, e lo si vede quando un/a autore/rice noto/a viene a fare una presentazione che si conclude col suo bravo firmacopie (operazione che per il momento è possibile solo su copie cartacee). Comunque le collezioni restano una risorsa di conoscenza che le biblioteche – se ne sono effettivamente in possesso, cioè se hanno una copia fisica – possono digitalizzare e mettere a disposizione di tutti in forma generalizzata: penso ovviamente alle collezioni storiche di testi e periodici, di stampe e altro. Nonostante tutti i progetti di digitalizzazione fin qui visti e tutt’ora in corso grazie a quelli elaborati per sfruttare i fondi PNRR, non si vede all’orizzonte (in Italia) un contenitore unico comune che possa realmente essere semplicemente accessibile per tutti/e e la stessa cosa lo testimonia anche Library 2035 per la realtà statunitense segnalando il sottoutilizzo di una risorsa importantissima come Internet Archive.
Pur con le perplessità sopra riportate la lettura del libro è interessante, anche al di fuori del contesto americano, se non altro per mostrarci come, ancor più di quanto lo sia stato in passato, il futuro delle biblioteche è incerto ed oscuro, rischiarato solo, e per breve tratto, dai risultati fin qui raggiunti. Da segnalare anche la presenza nel testo dei link alle videointerviste a tutte le autrici e a tutti gli autori degli interventi che possono essere viste anche senza acquistare il libro a partire dalla pagina ad esse dedicata.
Link nel post:
pagina dedicata al libro sul sito dell’editore: https://rowman.com/ISBN/9781538180419/Library-2035-Imagining-the-Next-Generation-of-Libraries
post dedicato al libro di Jane McGonigal sulla nprevisione del futuro: https://ossessionicontaminazioni.blogspot.com/2022/06/immaginabile-il-nuovo-libro-di-jane.html
Internet Archive: https://archive.org
Raccolta delle videointerviste ad autrici e autori dei contributi presenti in Library 2035: https://sites.google.com/sjsu.edu/library2035/home

Lascia un commento